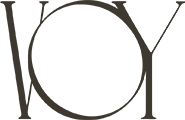L’arcobaleno del marketing
Il Pride Month Siamo a giugno. E c’è un evento, accaduto proprio in questo mese, che ha lasciato un segno nei calendari estivi degli ultimi decenni. Un segno che è destinato a rimanere, inciso, negli anni a venire.
Tra il 27 e il 28 giugno 1969, a Manhattan, presso il Stonewall Inn, storico – se pur malfamato – locale gay della scena newyorkese, avvenne l’ennesima retata della polizia volta all’identikit e all’arresto delle persone presenti nel locale. Nulla di nuovo, in realtà, per la comunità queer degli anni 60’, abituata a convivere con l’idea che la libertà, seppur confinata alla notte e all’interno di locali dedicati, dovesse essere pagata con il prezzo della paura e del timore di poter finire arrestata dalle forze dell’ordine per un pretesto qualsiasi. Se normalmente si sarebbe accettato l’ennesimo sopruso, per poi riaprire abusivamente, quella volta avvenne qualcosa di diverso. Il contesto delle lotte di liberazione delle persone nere e i movimenti del ‘68, avevano aiutato la comunità gay – al tempo era ancora opportuno definirla così; ad oggi, si parla di LGBTQ+, o queer – a costruirsi un’identità più forte, così come più forte era la pretesa della libertà individuale. All’arrivo delle forze dell’ordine, lə presenti dello Stonewall si ribellarono, riuscendo, grazie alla partecipazione complessiva di circa 2000 persone, a sopraffare la polizia. Ecco i Moti di Stonewall.
La storia è certamente più lunga e viene spesso arricchita di dettagli che si muovono sui binari dell’iconografia e della leggenda piuttosto che dell’accuratezza storica; ciò che conta però è che questo evento fu il segno, per la comunità queer, della possibilità di unirsi per ottenere con successo la propria libertà. Nel mese successivo nacque il movimento del Gay Liberation Front (GLF), destinato a diffondersi e declinarsi prima in tutti gli Stati Uniti, e poi in tutto il mondo. L’anno successivo, il 27 giugno 1970, venne organizzata proprio dal GLF una marcia commemorativa dei moti di Stonewall, a cui parteciparono diverse migliaia di persone. E se ne organizzarono altre, dagli Stati Uniti, all’Europa e poi in tutto il mondo; dal 1970 fino ad arrivare ad oggi. Se “marcia commemorativa per i moti di Stonewall” non dovesse suonare sufficientemente familiare, lo sarà di certo il nome che questo tipo di evento assunse negli anni a seguire: la marcia del Pride. Sarà poi Bill Clinton, nel 1999, il primo a proclamare a livello istituzionale la convenzione, già consolidata nell’attivismo queer, del mese di giugno come “Gay and Lesbian Pride Month”, proprio per commemorare l’evento simbolo dell’attivismo LGBTQ+.
Con il passare del tempo, il Pride Month si è diffuso sempre di più nel mondo mainstream, anche per via del supporto offerto a questa celebrazione dai più svariati marchi, brand e multinazionali, i quali ad inizio estate arricchiscono la propria offerta di consumo con prodotti a tema. Ciò tende a tradursi con una riverniciata arcobaleno di alcuni dei pezzi già precedentemente presenti in listino. Seppur a prima vista possa apparire qualcosa di semplicemente positivo, bisogna fare chiarezza su quello che è un impegno attivo da parte di un’azienda nel sostenere i diritti LGBTQ+ rispetto alla semplice, asettica, strategia di marketing. Ma facciamo un passo, o due, indietro.
Think Before you Pink
Nel 2002 la Breast Cancer Action (BCA), organizzazione statunitense che si muove per la giustizia sanitaria delle donne affette da tumore al seno, lanciò una campagna chiamata Think Before You Pink. Lo scopo originario del progetto, ancora presente come portale web, era ed è quello di combattere la diffusione dell’utilizzo del simbolo internazionale della lotta contro il tumore al seno, il nastro rosa, da parte di brand che monetizzano su quest’ultimo senza tuttavia adoperarsi a supportare la ricerca e la sensibilizzazione sul tema. Come nel caso del termine “sostenibile” a fini commerciali, di cui abbiamo parlato in due articoli precedenti, anche l’utilizzo di simboli come il nastro rosa non è regolamentato da normative nazionali o internazionali; la sua presenza su un prodotto non garantisce dunque a consumatori e consumatrici una politica aziendale di attivo supporto alla causa. Ci troviamo di fronte, dunque, ad un altro tipo di -washing, né white né green, che prende il nome di pinkwashing.
Con il passare del tempo, l’utilizzo di questo termine si è differenziato: da una parte identificando specificatamente l’utilizzo inappropriato del nastro rosa come denunciato dalla Breast Cancer Action, dall’altro includendo anche le istanze riguardanti il mondo queer. Per quest’ultimo, però, è spesso preferibile l’utilizzo del termine rainbow-washing.
Ma qual è l’interesse di un’azienda nel dimostrarsi queer-friendly a fini di marketing?
Soldi rosa e lavaggi arcobaleno
Secondo la rivista FORBES, nel 2019, il potere d’acquisto delle persone LGBTQ+ adulte è stato stimato intorno ai $3.7 trilioni di dollari. Per capirci, un trilione sta per un miliardo di miliardi: parecchi soldi, insomma. In Italia, le stime sul numero di potenziali clienti del “mercato arcobaleno”, variano tra i 3 e i 6 milioni; la stessa fetta di consumatrici e consumatori oscilla invece, in Europa, tra i 37 e i 74 milioni di persone, raggiungendo i 700 milioni in tutto il mondo. Questo senza contare chi non si riconosce direttamente nella comunità, ma può comunque compiere scelte di consumo interne a questo mercato.
Inoltre, un articolo della BBC (“Business: The Economy: The Pink Pound”), indica che “fino al 90% delle persone gay statunitensi supporterebbe aziende che targettizzano i pink money, boicottando attivamente compagnie anti-gay”. Alla luce di questi dati, e considerando che la fascia di popolazione queer nei vari paesi del mondo è storicamente poco rappresentata, una selezione di prodotti rivolta proprio a loro può essere per molte aziende una garanzia di vendita molto interessante.
Tutto ciò si chiama Queer Marketing. Di per sé, offrire prodotti che possano soddisfare le richieste della popolazione LGBTQ+ non è necessariamente qualcosa di sbagliato. Il problema è lo sfruttamento di simboli, slogan ed eventi specifici – primo tra tutti, per l’appunto, il mese del Pride -, per darsi un’immagine di interesse sociale che non si intende rispettare nei fatti.
La lista di passati storici, a questo punto, si fa lunga: dai più esemplari come quello di Chiara Ferragni, con la linea arcobaleno Love Fiercely nel 2020, progettata senza la previsione di una donazione ad alcun tipo di associazione o struttura LGBTQ+; fino al caso di Primark, che nel 2018 lanciò una linea appositamente pensata come merchandising degli imminenti Pride europei – con cappellini e magliette arcobaleno riportanti, per l’appunto, la scritta Pride
– senza allo stesso tempo aver partecipato economicamente alle organizzazioni dell’evento a livello locale. Sebbene il 20% di tali vendite sarebbe stato devoluto all’associazione inglese Stonewall, le località in cui i prodotti di Primark sono assemblati, come la Turchia e il Myanmar sono storicamente lontane dal rispetto dei diritti umani di questa categoria. Inoltre la percentuale della donazione, fu considerata da moltə irrisoria rispetto agli introiti portati da un’iniziativa così targetizzata, rendendo la campagna un esempio di rainbow-washing da manuale.
Un esempio positivo, d’altra parte, potrebbe invece essere quello di Calvin Klein, che nel 2020, con la campagna Proud in My Calvins, vestì molti personaggi di spicco della comunità LGBTQ+ internazionale, mentre raccoglieva fondi per la comunità queer statunitense colpita da COVID-19, stringendo partnership con OutRight Action International e The Equality Project e facendosi sponsor di PFLAG National, la principale organizzazione sul tema negli USA.
Come posso proteggermi dal rainbow washing?
Come per gli altri tipi di washing di cui abbiamo parlato, ci sono alcuni fattori che possono aiutarci a riconoscere brand che realmente si impegnano nel difendere i diritti LGBTQ+.
1.Il vero supporto è tutto l’anno
l brand che lottano per i diritti LGBTQ+ lo fanno tutto l’anno, non si limitano a riempirsi le tasche colorando i propri prodotti con arcobaleni nel mese di giugno.
Con un po’ di ricerca è facile controllare l’operato dei tuoi brand e scoprire se realmente si sono occupati di questo tema con costanza.
2. Il loro supporto alla causa queer ha risultati tangibili
Tra il dire e il fare c’e di mezzo il washing.
I marchi che hanno a cuore i diritti LGBTQ+ non si limitano a un cambiamento estetico del loro brand ma impiegano i loro soldi e le loro azioni al servizio della causa.
Questi marchi danno un sostegno misurabile e sono anche trasparenti su chi e cosa supportano e perché.
3. Collaborano con organizzazioni e collettivi queer
Uno dei metodi più efficaci per avere risultati tangibili è quello di affidarsi alle organizzazioni e i collettivi LGBTQ+ che svolgono un lavoro fondamentale, ma sono spesso sotto finanziate.
4. Assumono e creano spazi per membri della comunità
Evitando l’inclusione pro forma, i brand che supportano i diritti LGBTQ+ impiegano, supportano e amplificano le voci di persone queer all’interno della propria azienda.
5. Sono attenti al feedback
Nel supportare i diritti LGBTQ+, questi brand interpellano i membri della comunità e rispondono alle loro reali necessità.
By
wp_13427506
0 Comments
Share:
Related posts
COP26 PART I
È iniziata il 31 ottobre a Glasgow, in Scozia, la COP26. Come richiama la sigla, per l’appunto, s
COP26 PART II
Ci siamo lasciati con una catastrofe in arrivo, incombente e minacciosa. Ci siamo lasciati con i ton
GREEN OR GREED?
Nel dibattito sull’ecosostenibilità, c’è un grande tema che negliultimi anni ha preso, a merit