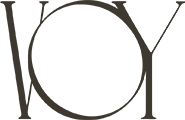THINKING SLOW
Thinking Slow: il vero costo del Fast Fashion
Da anni ci siamo abituatə a farci vanto di essere riuscitə ad acquistare capi d’abbigliamento a prezzi bassissimi. Oggi è possibile comprare un vestito a €5 da molti dei più grandi retailer. Ma in quali mani finiscono i soldi che abbiamo speso?
Considerando che una parte del prezzo di un capo è destinato a coprire le spese di gestione e acquisto delle materie prime, e un’altra buona parte costituisce il ricavo dell’azienda produttrice, è piuttosto evidente che il denaro destinato a chi quel vestito l’ha prodotto in prima persona sia estremamente irrisorio. Inoltre, quali materiali vengono utilizzati e come vengono prodotti al fine di mantenere un prezzo così competitivo?
La velocità della moda
Il Fast Fashion prende il nome dalla capacità di un certo brand di lanciare nuove collezioni in tempi brevissimi, e comprende tutta quella produzione di abbigliamento quasi monouso che utilizza materiali di bassa qualità a prezzi ridotti. Un rapporto della Commissione Europea ha rivelato che in Europa le aziende di moda sono passate dal presentare due collezioni all’anno nel 2000 a cinque nel 2011. Alcune, come Zara e H&M, arrivano persino a 24 all’anno, creando la necessità di comprare sempre nuovi indumenti per stare al passo con le nuove collezioni. Infatti, secondo il World Economic Forum, ogni anno vengono prodotti circa 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento. Il consumatore medio oggi compra il 100% in più rispetto a 30 anni fa e indossa i suoi acquisti circa sette volte prima di liberarsene.
Tuttavia, dietro al tag del prezzo di questi capi pagati pochissimo si nasconde un costo ambientale e sociale impressionante. Questo è un conto che i produttori non pagano certo di tasca loro: basta guardare a Inditex – che possiede Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe –, la quale nel 2019 ha registrato un utile netto annuo di 3,44 miliardi di euro.
Un disastro ambientale
L’industria della moda è il secondo più grande inquinatore mondiale, subito dopo l’industria petrolifera. Un rapporto dell’ONU dimostra infatti che la moda produce il 20% delle acque reflue globali e il 10% delle emissioni di carbonio. Le acque reflue rese tossiche dalla tintura dei tessuti vengono scaricate direttamente nei fiumi e sono dannose sia per la vita marina che per la salute di tutti, dato che non solo queste sostanze contaminano le acque dei fiumi in cui vengono rilasciate, ma anche il mare, diffondendosi in tutto il mondo. L’acqua è poi contaminata anche tramite i fertilizzanti utilizzati nella coltivazione del cotone.
È importante ricordare lo sfrenato consumo di acqua portato avanti dall’industria della moda; per capire l’entità del problema basta pensare che secondo il WWF ci vogliono circa 2.700 litri di acqua per produrre una singola maglietta di cotone. In paesi in cui c’è scarsità di acqua, la produzione di cotone non può che aggravare la situazione già precaria di molte popolazioni. In un articolo del Guardian, Stephen Leahy riporta che “nel 2013 l’acqua consumata per coltivare il cotone indiano da esportazione sarebbe sufficiente per soddisfare
l’85% della popolazione indiana con 100 litri d’acqua ogni giorno per un anno. Nel frattempo, in India 100 milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile”.
A questo si aggiunge il fatto che la mentalità da fast fashion fa sì che la vita degli indumenti sia molto corta. Questo non solo innesca una produzione eccessiva – la quale, come abbiamo visto, porta effetti disastrosi sull’ambiente -, ma significa anche che, ogni secondo, l’equivalente di un camion della spazzatura di tessuti viene messo in discarica o bruciato. Secondo l’ONU, se questi dati rimanessero invariati, entro il 2050 l’industria della moda utilizzerà un quarto del budget mondiale di carbonio.
Una questione di diritti umani
Per mantenere i prezzi al ribasso, il fast fashion logora vite umane e soprattutto quelle di donne e bambine. Secondo la campagna Labour Behind The Label, circa l’80% di coloro che lavorano nella filiera tessile sono donne di età compresa tra 18 e 35 anni.
La filiera tessile rappresenta inoltre la seconda industria in cui persone, e principalmente appunto donne e minori, sono più a rischio di schiavitù moderna. L’indice Global Slavery stima, infatti, che 40 milioni di persone oggi vivano in condizioni di schiavitù moderna, di cui una gran parte vive nel Sud del mondo e lavora nelle grandi catene di fornitura dei marchi di abbigliamento occidentali.
Queste sono persone che vengono sfruttate in fabbriche con scarsa ventilazione e accesso all’acqua e vengono esposte a sostanze chimiche dannose per la vita umana. Persone che lavorano turni massacranti e spesso percepiscono un reddito che non supera i €100 al mese.
Per alcuni dei salari più bassi del mondo, milioni di persone sono esposte ad altissime percentuali di incidenti e decessi sul lavoro. Come riporta l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), dato che la maggior parte delle fabbriche di fast fashion non soddisfa gli standard minimi in materia di edilizia e costruzione, le morti per incendi e crolli di edifici sono frequenti. Incidenti come quelli del 2013, quando crollò la fabbrica Rana Plaza a Dhaka, in Bangladesh, e uccise almeno 1132 persone e ne ferì più di 2500.
Cosa possiamo fare per cambiare questa situazione?
Dato che le conseguenze del fast fashion sono disastrose sia sull’ambiente che sulle vite umane di persone reali, è necessario prendere posizione e fare la propria parte per finanziare realtà che abbiano realmente intenzione di investire energia e denaro per abbattere questi sfruttamenti inaccettabili.
- Informati
L’informazione genera consumatori e consumatrici consapevoli. Informati il più possibile sull’industria del fast fashion e il reale costo di questa pratica. Oltre alle risorse già citate nell’articolo, noi abbiamo trovato particolarmente utile il documentario The True Cost.
Sui social, inizia a seguire le pagine e i portali che divulgano scienza e pratiche sostenibili, o nuovi brand che rispettino i tuoi nuovi valori; allo stesso tempo togli il follow a tutte quelle realtà che vivono di advertising per alimentare il tuo desiderio di consumo inconsapevole. Circondarti delle informazioni e immagini giuste è il modo più semplice per indurre il tuo desiderio di cambiamento e abituarti a una nuova modalità di consumo.
2. Occhio al greenwoshing
Abbiamo chiarito che un prezzo estremamente basso sia un indicatore evidente di politiche aziendali insostenibili. Il contrario non è però sempre vero, così come le promesse di attenzione al tema potrebbero essere motivate da un interesse economico piuttosto che sociale e ambientale. Se ti serve un ripasso sul greenwashing, qui puoi trovare un articolo che Nereidi ha pubblicato il mese scorso sulla questione.
Inoltre, esistono iniziative che possono aiutarti a conoscere le pratiche di molti brand. Per esempio, Good On You valuta i tuoi brand preferiti per aiutarti a fare scelte migliori. “Scelte che riflettono il tuo impegno a fare meglio per il pianeta, le persone e gli animali. Scelte che creano un futuro sostenibile nella moda.”
3. Compra meno e molto meglio.
Hai davvero bisogno di tutti quei vestiti? Ridurre i nostri consumi valorizzando ciò che già possediamo o che possiamo procurarci senza generare nuovo spreco è il primo passo fondamentale. Inoltre, come abbiamo ribadito più volte, il consumatore e la consumatrice hanno l’enorme potere di influenzare l’offerta di mercato. Pondera bene ogni nuovo acquisto, e, quando risulta necessario, affidati a creativə e artigianə che con le loro mani e idee possono offrirti qualcosa che sia veramente di qualità. Per quanto riguarda invece acquisti a budget ridotto, puoi sostituire il fast fashion con i negozi e i mercati di seconda mano: la soddisfazione di quando si trova il pezzo giusto sapendo di spendere poco e di ridare vita a qualcosa che altrimenti sarebbe scarto, non ha eguali.
Isabella Cordua,
Edoardo Andreoli &
Nereidi Studio
Related posts
SECOND HAND SEPTEMBER: L’USATO PRIMA E DOPO
Da qualche anno la Oxfam, importante organizzazione internazionale che lavora per l’abbattimento d
POSSIAMO FIDARCI DEI DATI?
Che cos’è un dato? Lisa Gitelman, professoressa all’Università di New York di Media e Co
SECOND HAND SEPTEMBER: USATO E GENTRIFICAZIONE
La scorsa settimana abbiamo visto in che modo si sia evoluto il mercato dei capi di abbigliamento di